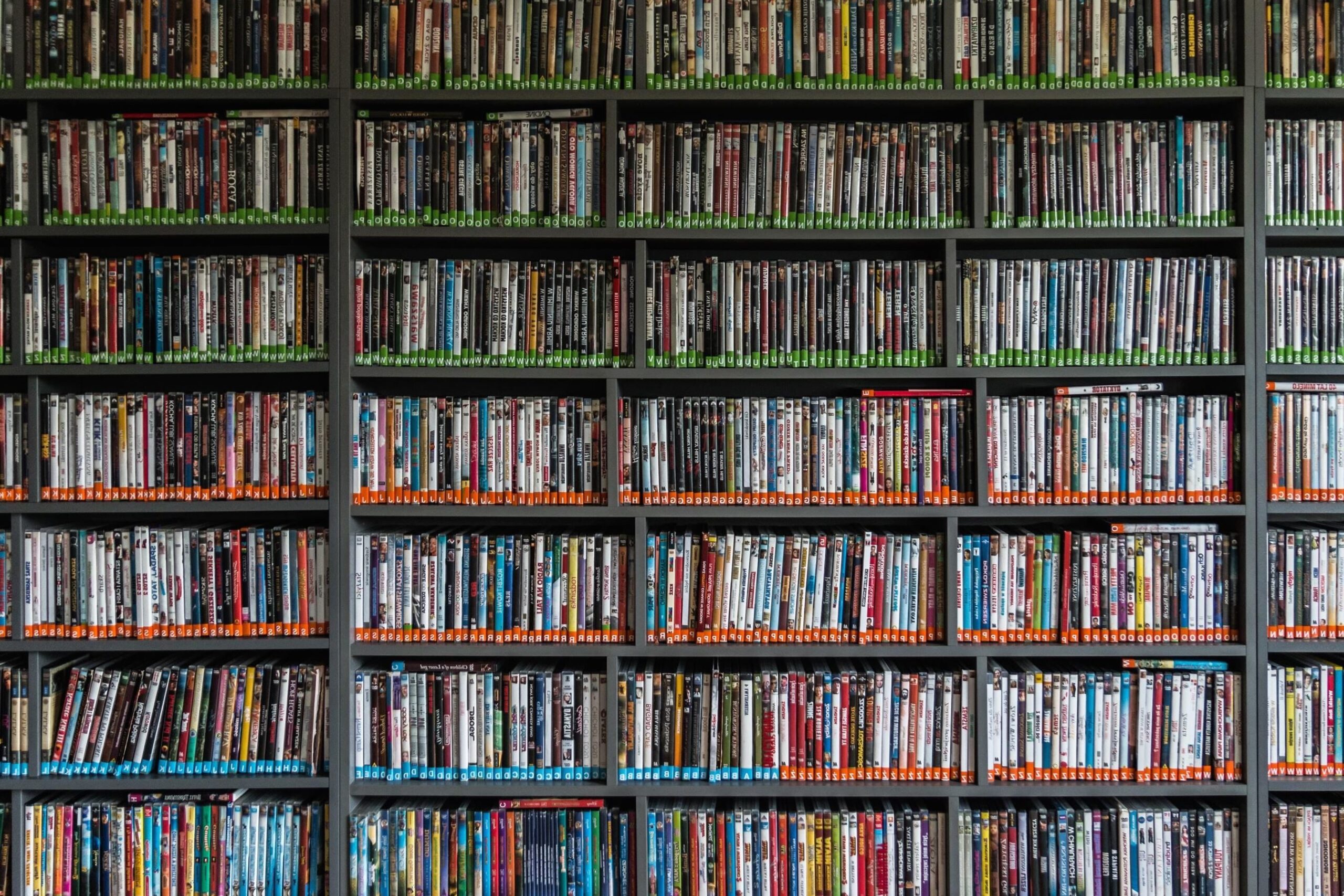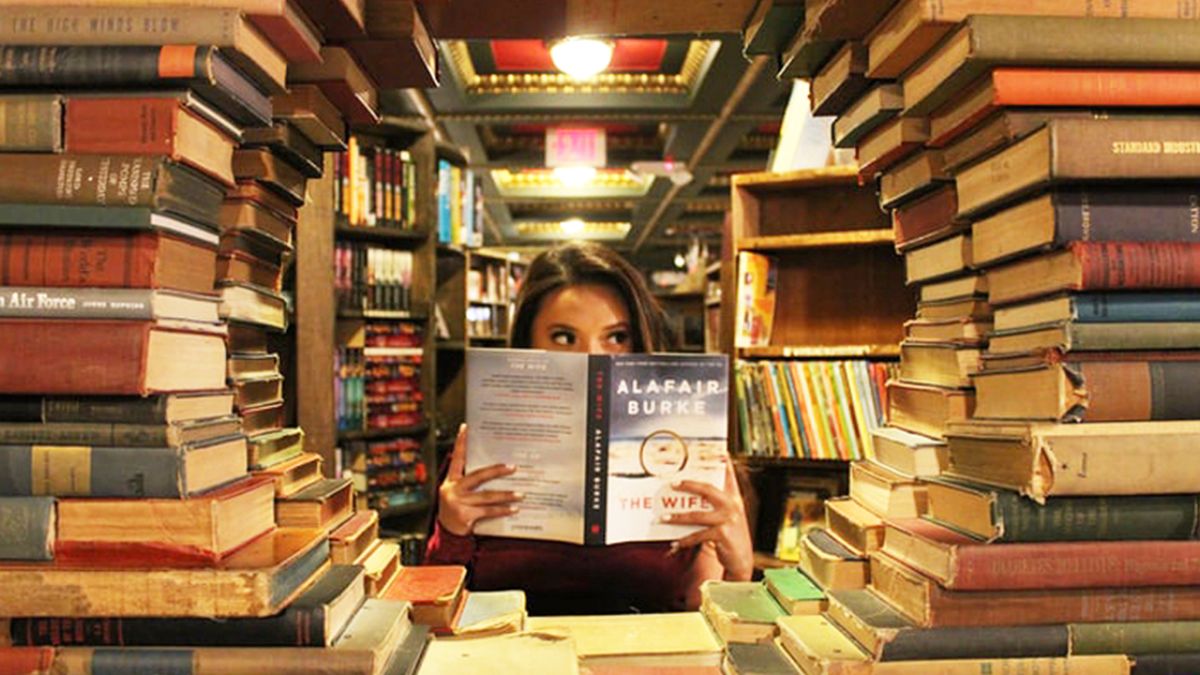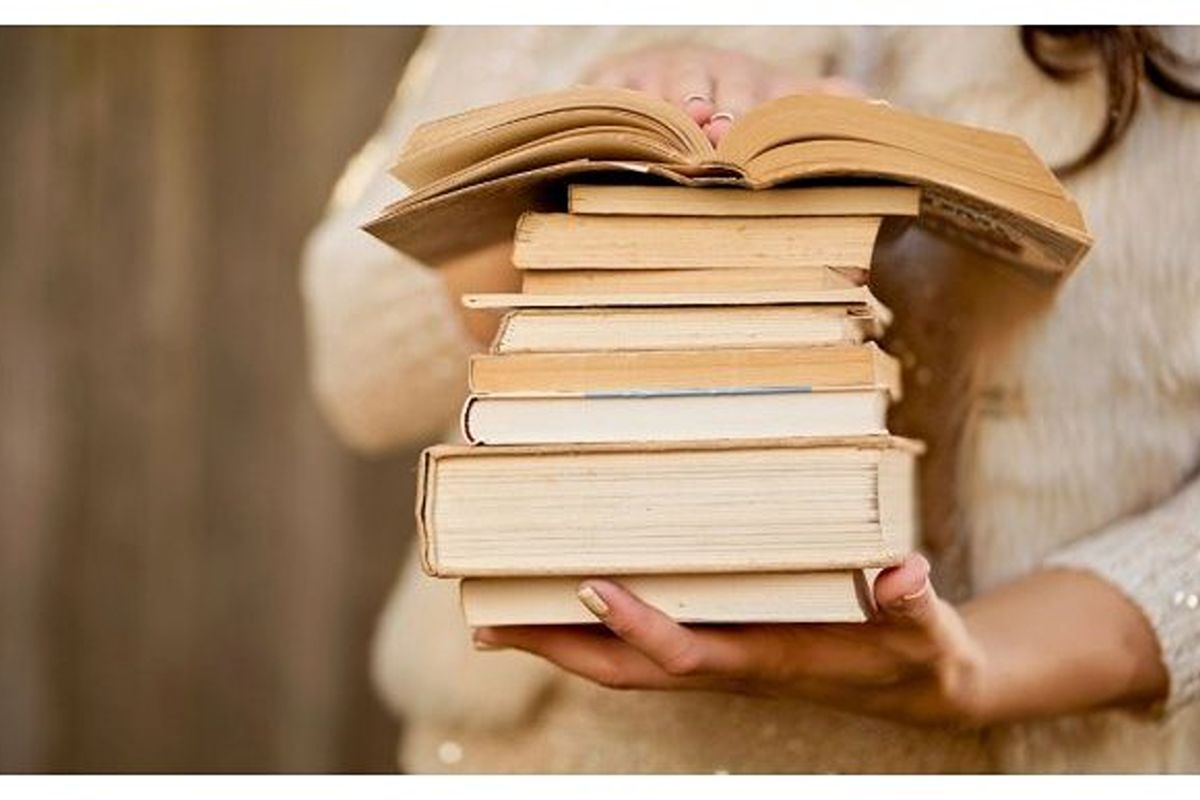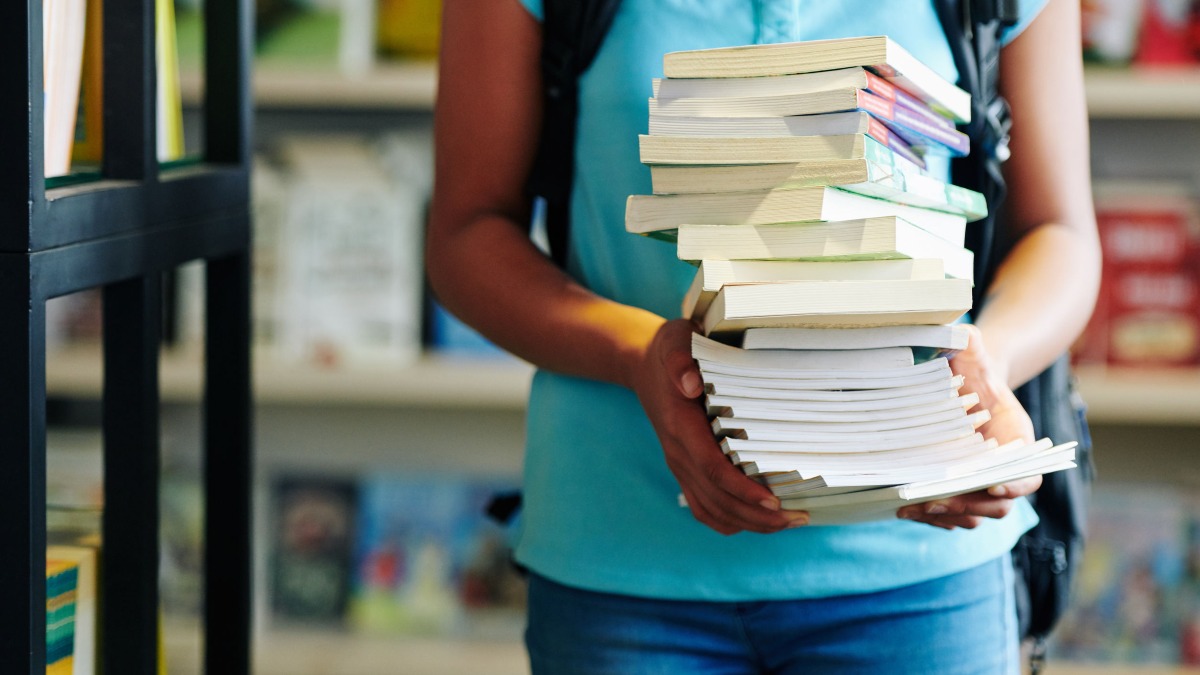di Cinzia Mescolini
Attraverso la lettura critica della Teoria dell’argomentazione del filosofo belga Chaïm Perelman – pubblicata per la prima volta in Francia nel 1958 e poi in Italia nel 1966 con la prefazione di Norberto Bobbio – Stefano Cazzato affronta in “Chaïm Perelman. Retorica, etica, politica” edito da Ladolfi Editore, alcuni nodi cruciali nell’evoluzione del pensiero novecentesco che riguardano non solo la retorica come arte di persuadere con la parola, ma anche l’etica e la politica. Nel processo comunicativo dell’agorà, da intendersi come luogo di confronto e dibattito, l’argomentazione diventa infatti inevitabilmente atto politico. Ciò presuppone il riferimento all’etica e dunque al Diritto. All’interno di tale paradigma generale, le variabili evidenziate dal ragionamento di Stefano Cazzato sull’opera filosofica di Perelman, stimolano dubbi e riflessioni di grande attualità.
Ed è qui il pregio più significativo di questo piccolo volumetto, edito da Giuliano Landolfi Editore nella collana Perle, che unisce, alla brevità, la chiarezza espositiva. Il linguaggio, che pure mantiene la precisione della disciplina, consente infatti anche a chi non ha una formazione filosofica di entrare nel pensiero di Chaïm Perelman e di aprire scenari, a partire dalla lettura proposta, sulla eredità e le conseguenze della teoria dell’argomentazione nel dibattito contemporaneo. Cosa accade infatti nel momento in cui l’arte della persuasione non fa riferimento a un’etica come sistema di valori condivisi? Quali sono le conseguenze se quello stesso sistema valoriale su cui sembrava naturale fondarsi la retorica, non è più universalmente riconosciuto e riconoscibile?
Si tratta di interrogativi che ridefiniscono confini, aprono controversie, invadono il terreno dell’opinabile, dove l’arte stessa della retorica può argomentare ogni cosa e il suo contrario, fino a farsi impegno, potere politico, ma anche propaganda e manipolazione. Se per un verso infatti la questione si riferisce a un approccio tutto novecentesco che contempla la capacità di svincolarsi da verità assolute in contrapposizione ai legacci stringenti delle ideologie, al contempo ha anche a che fare con il relativismo assoluto dei valori che può condurre alla stessa dissoluzione dei confini tra il bene e il male. Nel mettere a fuoco alcuni nodi concettuali complessi – quali il libero arbitrio, il processo decisionale del singolo, l’universalità o la relatività dei valori, fino alla funzione “politica” dell’ironia – Stefano Cazzato, con una prosa cristallina, conduce il lettore dentro e fuori le sue certezze. Nel fare ciò, ne scardina i pregiudizi stimolando, inevitabilmente, la riflessione.