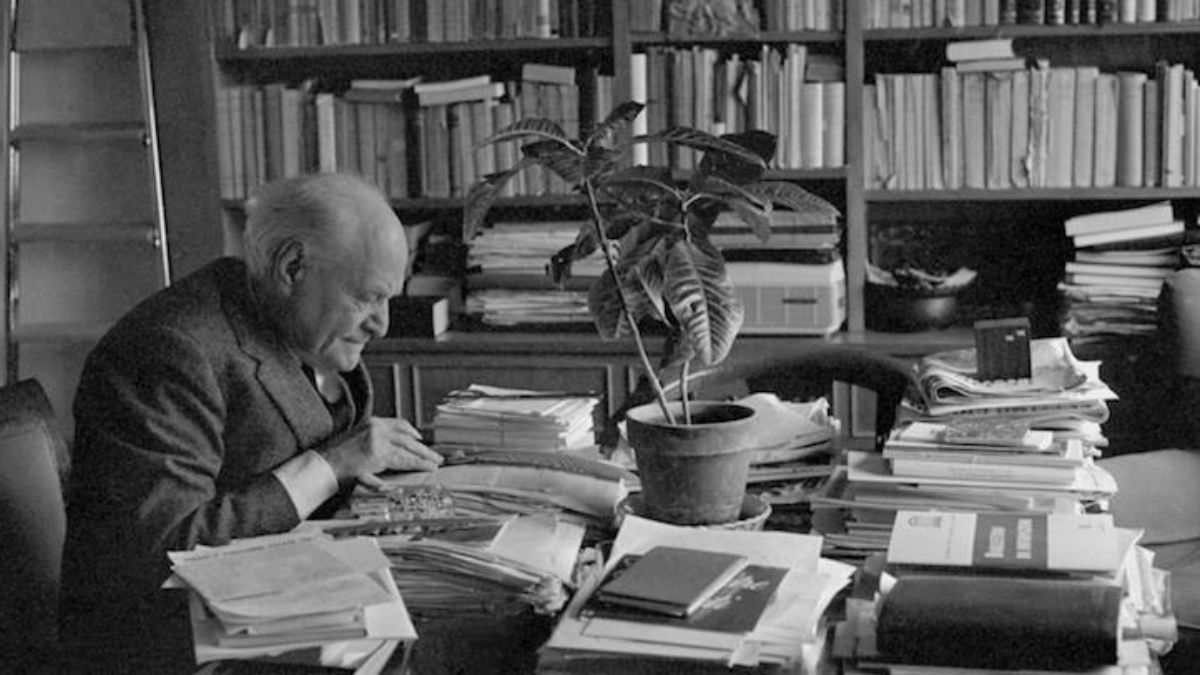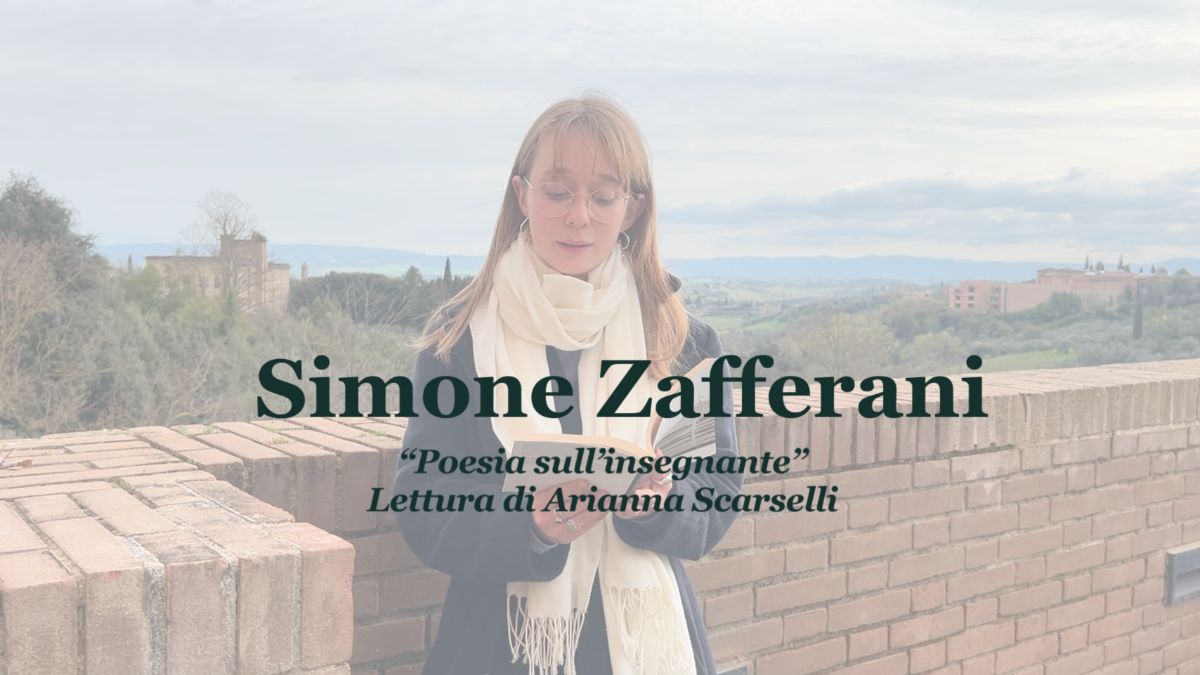di Antonio Picarazzi
Cosa può fare la poesia davanti all’orrore? In un tempo in cui la narrazione del dolore spesso passa per immagini crude, bollettini di guerra o retoriche politicizzate, «Il loro grido è la mia voce» (Fazi Editore, 2024) offre una forma di resistenza radicalmente diversa: quella della parola poetica.
A curare questa raccolta sono Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti, con un lavoro editoriale che ha il merito non solo di dare spazio a una pluralità di voci palestinesi contemporanee, ma anche di offrirle in modo sobrio, senza compiacimenti né vittimismi.
Il titolo stesso è già una dichiarazione di poetica: il grido non è solo un richiamo all’urgenza del dolore, ma anche una trasfusione, un passaggio di testimone. La voce del poeta non è più sua, diventa quella degli altri. Di chi non può più parlare, di chi è stato zittito. Di chi, come Heba Abu Nada, ha perso la vita a Gaza nell’ottobre 2023, ma continua a vivere nei suoi versi.
In questa raccolta, la poesia si spoglia delle sue ambizioni estetiche e si fa lingua della carne, del sangue, del lutto, ma anche della tenacia quotidiana. Ogni poesia è un frammento di umanità che rifiuta di piegarsi. Alcune sono scritte in condizioni estreme — sotto le bombe, nell’isolamento, nel pieno del blackout — eppure non gridano rabbia, ma custodiscono una forma di lucidità etica che sorprende.
I dieci poeti qui raccolti — tra cui Hend Joudah e Nima Hassan — non parlano solo di guerra. Parlano di maternità interrotte, di sogni mutilati, di amore, di cibo, di silenzi. E lo fanno in un arabo che, pur nella sua musicalità, si incide nella pagina come se fosse inciso nella pietra.
La scelta del testo a fronte è un gesto politico oltre che editoriale. Leggere l’arabo accanto all’italiano ci ricorda che ogni traduzione è un ponte, ma anche una frontiera. I traduttori — tra cui spiccano i nomi di Nabil Bey Salameh, Ginevra Bompiani ed Enrico Terrinoni — non tentano di addolcire o di spiegare: lasciano che le parole esplodano con la stessa forza con cui sono nate.
La prefazione di Ilan Pappé, storico israeliano noto per il suo dissenso, colloca il libro in una cornice di responsabilità storica. Ma il vero cuore pulsante di questa raccolta è nella sua scelta di destinare parte dei proventi (5 euro a copia) a Emergency per operare a Gaza. Qui la poesia non è solo documento: è gesto attivo, è solidarietà incarnata.
«Il loro grido è la mia voce» è un libro che non si può semplicemente “leggere”: va ascoltato, va attraversato. È un documento letterario, certo, ma anche un atto civile. È una mano tesa verso chi soffre, ma anche uno specchio che ci chiede: che cosa stiamo facendo, noi, con le nostre parole? Come possiamo essere voci, anche quando il mondo ci chiede silenzio?
È una mano tesa verso chi soffre, ma anche uno specchio che ci chiede: che cosa stiamo facendo, noi, con le nostre parole? Come possiamo essere voci, anche quando il mondo ci chiede silenzio?
I versi di Ni’ma Hassan, presenti in questa raccolta, risuonano con questa urgenza:
“Una madre a Gaza non dorme…
Ascolta il buio, ne controlla i margini, filtra i suoni uno ad uno
per scegliere una storia che le si addica,
per cullare i suoi bambini
E dopo che tutti si sono addormentati,
si erge come uno scudo di fronte alla morte
Una madre a Gaza non piange
Raccoglie la paura, la rabbia e le preghiere nei suoi polmoni,
e attende che finisca il rombo degli aerei,
per liberare il respiro
Una madre a Gaza non è come tutte le madri
Fa il pane con il sale fresco dei suoi occhi…
e nutre la patria con i suoi figli.”
Questa poesia, come tutte quelle raccolte in “Il loro grido è la mia voce”, non ci permette di rimanere indifferenti. Ci costringe ad ascoltare quel grido e a interrogarci sul nostro ruolo.