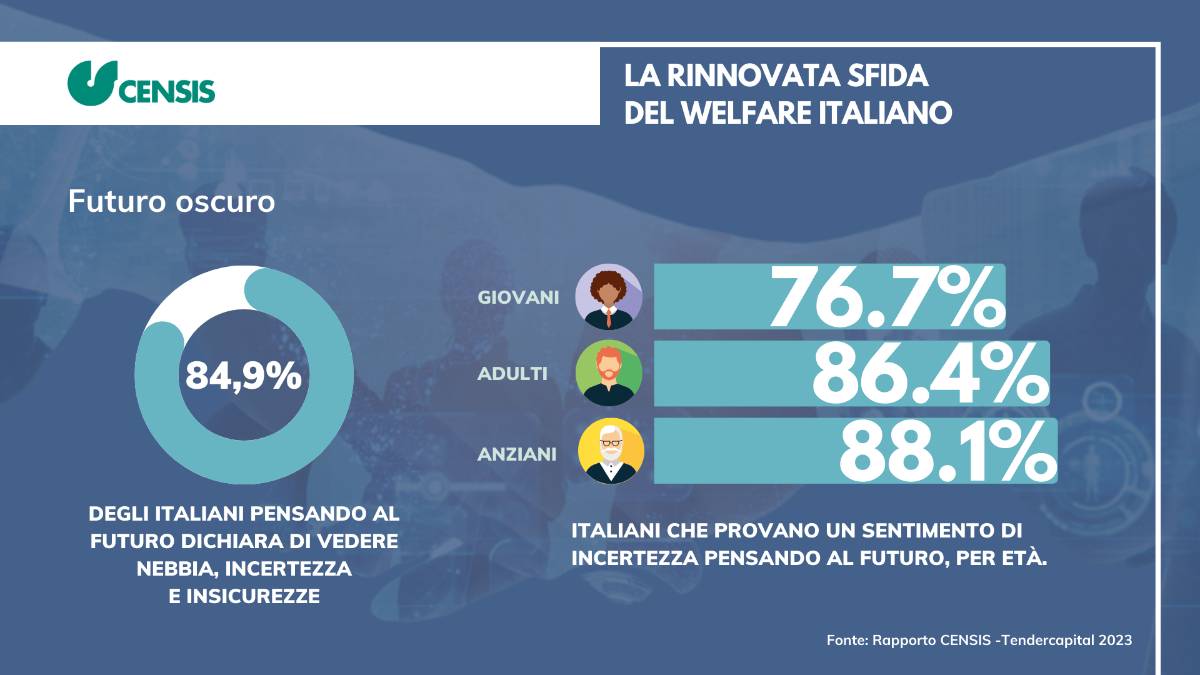Antonio Salvati
L’ultimo Rapporto Censis ci racconta la «società ansiosa di massa» e soprattutto dell’evocazione diretta del “sovrano” in carne e ossa, idealizzato e acclamato da più o meno la metà degli italiani. Stretti tra ansia di massa e incertezza del futuro, alla difficoltà di fidarsi degli altri accompagniamo il desiderio che arrivi un uomo forte a cambiare le sorti del Paese (e le proprie). Per natura noi ci fidiamo poco degli altri. Dobbiamo sempre dimostrare di essere noi a decidere ogni cosa: non sta bene far vedere che si dipende da qualcosa o da qualcuno, anche quando, nel fare così, facciamo come tutti e diventiamo gregari.
In particolar modo – racconta l’ultimo Rapporto Censis – dipendiamo molto dal nostro smartphone. Al mattino per prima cosa guardiamo cosa c’è di nuovo nei “social”. La sera si va a letto facendo l’ultimo tour su internet. Il 51% degli utenti controlla il proprio telefono come primo e ultimo gesto della giornata. Sono i nuovi riti.
I social indubbiamente hanno un’enorme potenzialità, perché aiutano la comunicazione e permettono, tra l’altro, di far arrivare un messaggio a tanti in pochissimo tempo. Si tratta di strumenti che ci aiutano a pensarci insieme, a donare la nostra esperienza ad altri, a far conoscere contenuti che altrimenti resterebbero rinchiusi in circuiti limitati. E fanno sì che tutti, in linea di principio, possano accedere a informazioni altrimenti elitarie. Tuttavia, presentano anche alcuni gravi rischi.
È forte, nei social network, la tentazione del primato dell’apparenza sulla sostanza. I contenuti vengono spesso offerti senza una meditata mediazione personale e la velocità rende difficile le verifiche. È dilagante l’uso di semplificazioni eccessive. Schierarsi viene spesso ritenuto necessario. Si fa largo l’idea che, più che capire, si debba sempre “dire qualcosa”. Sembra necessario, per esistere, dichiarare, aggiungere, chiosare, invece di discernere, aspettare, verificare, meditare e riflettere. L’impulso a intervenire subito e con frequenza diventa istintivo e pericoloso, non di rado porta a ferire l’altro. Sappiamo, del resto, quanto sia facile condizionare il pubblico di qualsiasi media con giudizi inappellabili, che non entrano nella complessità delle persone e non la rispettano.
I social: utili ma i più efficaci nel propagare odio
I social – di cui non ci stancheremo di sottolinearne l’utilità – sono tra gli strumenti più efficaci nella propagazione dell’odio. Sono uno dei “luoghi” nei quali esso viene indotto, coltivato, ratificato ed espresso con maggiore intensità. Spesso l’hater, il protagonista di dichiarazioni su internet impregnate d’odio, nella concretezza della vita non arriverebbe a tanto. Sui social, invece, sembra ci si renda meno conto del peso delle proprie parole. Protetti dalla distanza, a volte dall’anonimato che funziona come un perfetto strumento di deresponsabilizzazione, si finisce per ferire l’altro volontariamente, o anche involontariamente, a volte per il solo gusto di farlo.
Tutto ciò può diventare drammatico nell’adolescenza, quando genera paura, vergogna, timore di rappresaglie, e si teme di raccontarlo a un adulto. Gli odiatori prendono di mira qualcuno che gli risulta semplicemente antipatico o che individuano come esponente di una categoria (uno dei potenti, uno di una determinata cultura o provenienza…) e colpiscono per distruggere. A volte, navigare sul web, tra le chat, assomiglia a farsi largo in una giungla. Ci sono trappole, sentieri attraenti che non si sa dove vanno. Anche lì l’uomo si può rivelare lupo per altri uomini. E come in ogni giungla vige la legge del più forte contro il più debole, del più furbo contro l’ingenuo, del “colpire prima è meglio”.
Difficile valutare
La rapidità della comunicazione contemporanea, e dunque il poco tempo a disposizione per una valutazione seria, rende difficile sapere come stanno veramente le cose. Di conseguenza, anche stabilire con esattezza se quel che è stato scritto è vero o no può apparire al singolo un esercizio impossibile. I social network, inoltre, ci inviano messaggi in base alle nostre scelte precedenti: la nostra interazione con essi conferma le nostre stesse preferenze e queste ci vengono continuamente “ricordate”, rafforzando ciò che abbiamo sempre pensato e che, per certi versi, vogliamo di nuovo sentirci dire. Tale affinità di noi con noi stessi ci è trasmessa sempre da un algoritmo. Anche per questo i social network sono strumenti che educano poco al senso critico, meno dei libri e dei quotidiani.
Lo scrittore statunitense Jonathan Franzen ha scritto: «Gli algoritmi invisibili di Facebook e Google ti guidano verso i contenuti con cui sei d’accordo, e le voci non conformi tacciono per paura di essere attaccate, vilipese o private dell’amicizia. Il risultato è una catena di messaggi in cui, da qualsiasi parte tu ti sia schierato, hai assolutamente ragione a odiare ciò che odi».
In un certo senso, la Rete è una sorta di “eternità senza perdono”, direbbe il cardinale Matteo Zuppi. Si può essere inchiodati a un momento della propria vita, a un errore, a una fase, come se fosse tutto se stessi e per sempre. E l’odio sa come utilizzare tutto questo, come ricattare e creare paura e nuova schiavitù. Niente si cancella davvero. E può durare anche dopo di noi.
Il libro di Stefano Pasta “Razzismi 2.0”
Per meglio comprendere questo fenomeno viene in nostro aiuto l’interessante volume di Stefano Pasta, Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online (Morcelliana, 2018 pp. 224, € 20) che, in particolar modo, descrive l’evoluzione dei razzismi e della loro categorizzazione; continua analizzando le caratteristiche dell’ambiente digitale che facilitano la propagazione dei razzismi e dell’odio; infine, una terza parte è dedicata alle proposte per suscitare anticorpi e attivismo digitale che non sono l’opposto dell’hate speech, ma si muovono verso l’assunzione di responsabilità personale.
Il versante educativo
Ha giustamente osservato Pier Cesare Rivoltella che il libro non si limita a muoversi sul piano dell’analisi del fenomeno, ma si sposta anche sul versante dell’intervento educativo. Non basta più educare lo spettatore, occorre anche educare il produttore che ogni spettatore è diventato grazie allo smartphone che si porta in tasca. Insieme al pensiero critico occorre sviluppare anche la responsabilità. Per questo il libro di Stefano Pasta è prezioso: fa capire molto bene e rappresenta uno dei primi risultati di una nuova fase per gli studi sulla cittadinanza e sulla Media Education.
Le considerazioni sviluppate da Pasta – spiega Milena Santerini – sono indispensabili strumenti che anzi tutto scelgono un approccio critico, anche se fiducioso, verso la comunicazione online; realizzano poi una lettura analitica e originale dei “razzismi” al plurale, affrontando il tema del classico “io non sono razzista però”, cioè la differenza tra pregiudizio e odio strutturati e quelli occasionali, ben più diffusi e a torto considerati inoffensivi; spiegano il rischio del ritorno di una “razza” accettabile socialmente; descrivono l’etnicizzazione e la semplificazione delle società attuali; analizzano le pedagogie popolari implicite della paura e del disprezzo.
Un’emergenza e una sfida educativa
Pertanto, la banalizzazione delle pedagogie d’odio e la deresponsabilizzazione dello stare in Rete non rappresentano soltanto un’emergenza da non sottovalutare, ma pongono una sfida educativa. La media education – avverte Stefano Pasta – è chiamata a produrre riflessione sulla presunta libertà della Rete e la libertà «di dire quello che si vuole», potenziale premessa a un discorso d’odio e di discriminazione.
Va invece affermato il concetto di libertà positiva proposto da Martin Buber, una “libertà di” essere persone inserite in un contesto, persone in grado di esprimere una propria idea, aperte all’incontro con l’altro, in relazione con le opportunità che offre la società circostante, compresa quella aumentata del Web. Per il filosofo ebreo tedesco: «si tende a considerare questa libertà, che si può chiamare evolutiva, come opposto della costrizione, dell’essere-obbligati-a. Ma l’opposto della costrizione non è la libertà, bensì lo sperimentare un legame. La costrizione è una realtà negativa, sperimentare un legame è una realtà positiva. La libertà è una possibilità, la possibilità riconquistata. Essere costretti dal destino, dalla natura, dagli uomini: il suo opposto non è essere liberi dal destino, dalla natura e dagli uomini, bensì essere legati e alleati al destino, alla natura, agli uomini».