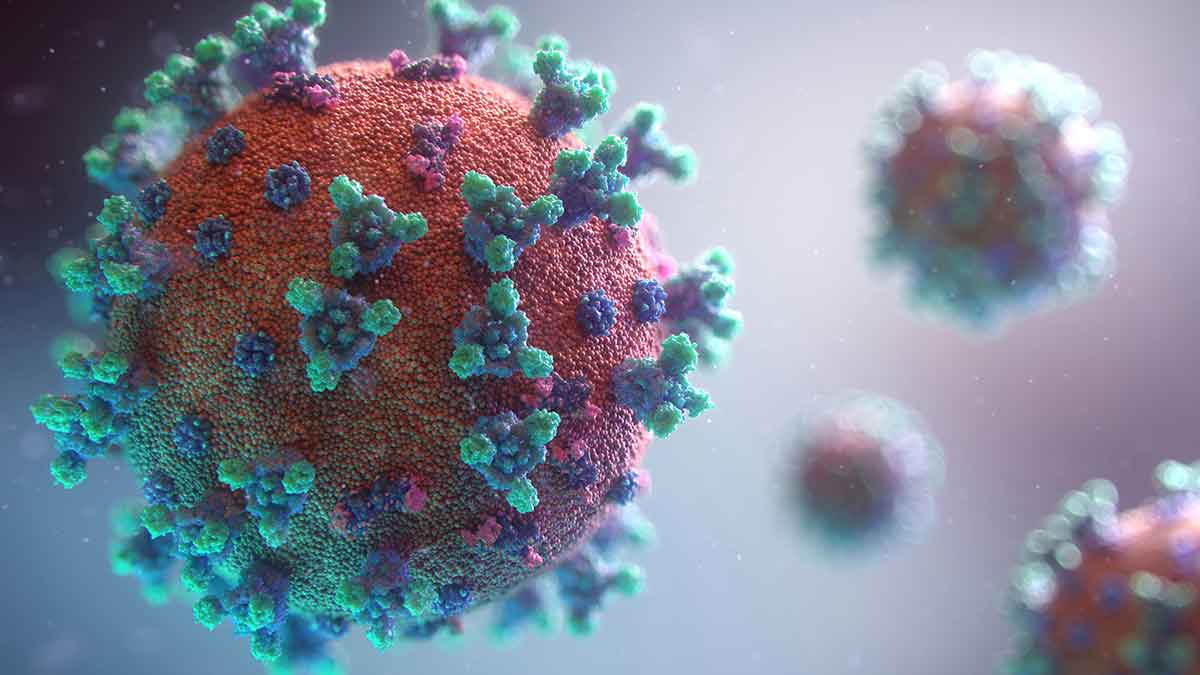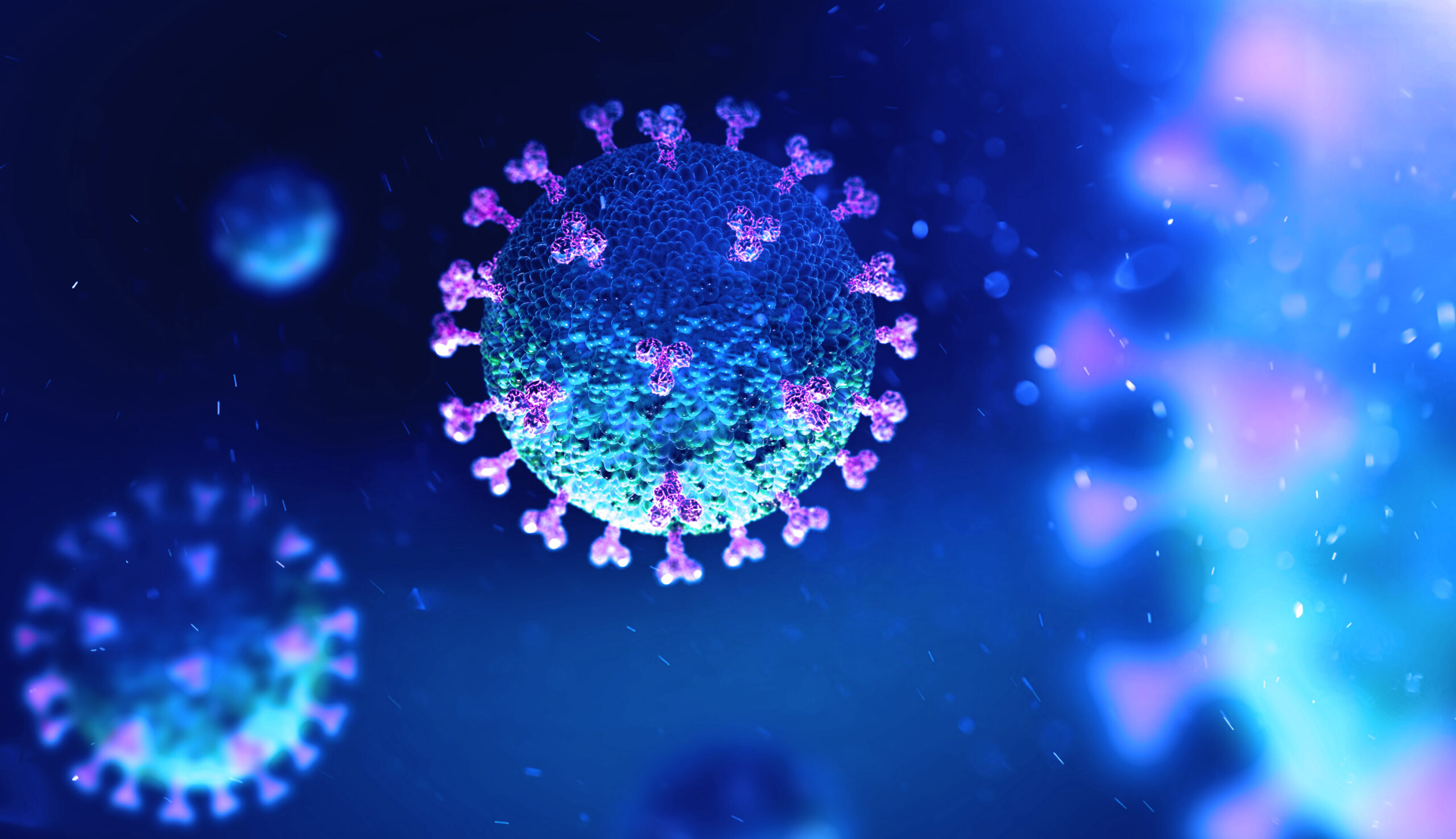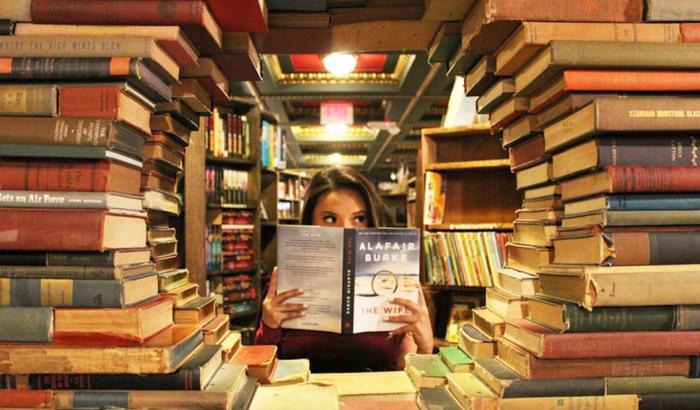“Ragazzi, mi sa che lunedì non ci vedremo”. Avevo chiuso così la lezione di mercoledì 4 marzo 2020, la terza del corso di Storia Medievale che tenevo all’Università di Siena. Dopo poche ore il governo aveva disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le Università italiane. Ero corsa, come tanti altri, a prendere le cose che pensavo potessero servirmi, mi ero caricata uno zaino di libri. Tempo qualche ora ed ero stata sommersa dalle mail di studenti ai quali ancora non sapevo cosa rispondere. Sapevo solo che, tranquilli, il corso continuerà. Tranquilli, vi farò sapere io come. Tranquilli, certo che ho tutti i vostri indirizzi. Tranquilli troverò il modo di fornirvi i libri.
A non essere tranquilla, naturalmente, ero io. Mentre l’Italia avviava il sistematico saccheggio dei supermercati, il mio frigo piangeva, ma non c’era tempo per fare la spesa, avevo altro da fare, anzi dovevo capire cosa e come fare, che era anche peggio. Alla fine del primo pomeriggio di travaglio, mentre si attivavano le chat dei professori di tutta Italia – dove si scarica quella piattaforma, come funziona – alle 19,45 il Magnifico rettore ci raggiungeva con la raggelante sequela dei “sono sospesi” “sono chiusi” “sono vietati” “non è consentito” cui ci siamo poi abituati. E ripeteva a noi docenti ciò che noi dicevamo ai nostri studenti. Tranquilli, ci stiamo organizzando, a ore avrete istruzioni.
E lunedì 9 marzo, alle ore 11, avviavo la mia prima lezione live, quasi un esperimento. Avete visto ragazzi, ci siamo tutti e stiamo bene. Nei giorni successivi invitavo nell’aula virtuale tanti studiosi a raccontare le loro ricerche, libri viventi al posto di quelli di carta che non potevamo sfogliare e commentare insieme. In fondo eravamo a casa ed eravamo tristi, cosa c’era di meglio che sentirsi utili?
Pensavo che la teledidattica mi avrebbe tradito, e per fortuna non è stato così. Con stupore mi sono accorta che molti prendevano la parola e che l’appuntamento con la lezione era divenuto un modo per mettere ordine nelle giornate che tendevano a perdere forma, per resistere all’abbrutimento, per vincere lo sconforto. Poco a poco, di là dallo schermo, avevo visto scomparire le tute e i capelli scomposti. Nell’ultima lezione ci siamo detti che non avremmo dimenticato facilmente, che ci eravamo tenuti per mano, che ce l’avevamo fatta. E che sarebbe finita presto.
Poi però non è finita presto. E’ passato un anno e sono stanca di vederci in uno schermo, stanca di non proseguire la lezione nel corridoio o davanti a un caffè. Mi commuovono quei quadratini di facce felici e sorridenti alla fine di cinque anni di studi, il giorno della Laurea. Ma sono stanca di non cogliere il lampo della comprensione nello sguardo di una studentessa, di non riuscire a vedere la noia in quello di un altro studente.
Sono stanca di fingere che non ci sia differenza tra far leggere un libro e avviare all’apprendistato della ricerca. Stanca di non mostrare col dito come si trascrive e interpreta un documento del XIII secolo, di non insegnare la storia dentro un archivio o in quelle aule a cielo aperto che sono le nostre città.
Abbiamo insegnato egualmente, certo, e al meglio che potevamo. Ma nessuno mi venga a dire che non c’è stata differenza, non si dica che è stato lo stesso insegnamento. Perché non è vero.
Ora si torna in aula e come molti professori anch’io, alla notizia della riapertura, ho avuto un moto di lievissima paura. Eppure è importantissimo disabituarsi allo schermo e riabituarsi alla vita dell’Università. Lo dobbiamo ai nostri studenti e (anche se in molti non abbiamo ancora fatto la seconda dose) lo dobbiamo a uno Stato che ci ha fatto vaccinare con corsia preferenziale proprio perché potessimo tornare in aula a fare il nostro dovere di professori. Dobbiamo tornare laddove insegnare ha un senso.
E con il passare delle ore la lieve paura si sta trasformando in un’emozione che ha il sapore del primo giorno. Si torna in aula e io sento davvero “un friccico nel core”.