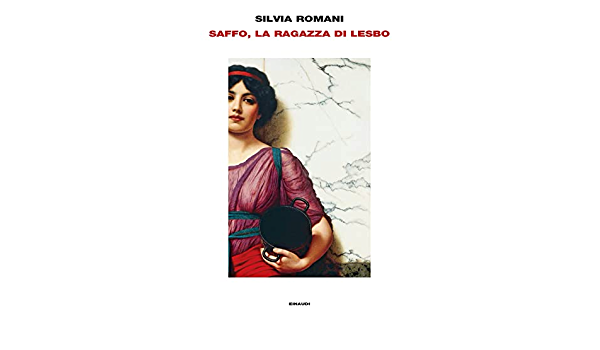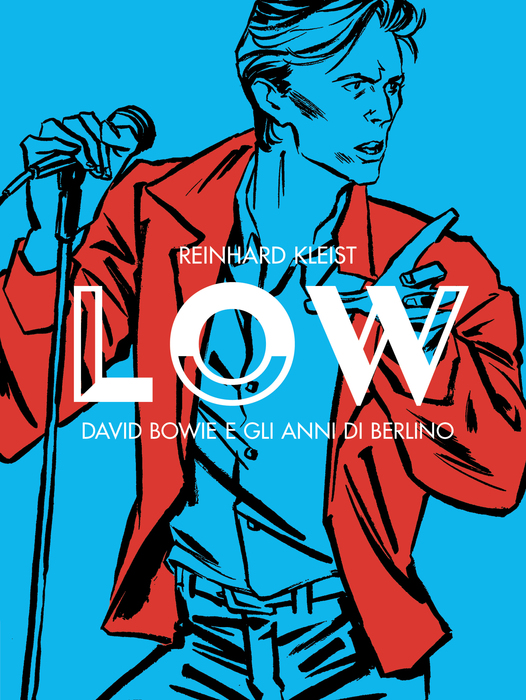di Gigi Spina
Leggere il libro di Silvia Romani, Saffo, la ragazza di Lesbo (Einaudi, Torino 2022), è stata per me una galoppata – spero che la metafora renda – guidata e orientata dal ritmo di una prosa narrativa che affronta sempre nuovi sentieri, svolte, deviazioni: una lettura anche con qualche scarto e impennata. Ogni tanto ho tirato le redini per prendermi un momento di pausa e di riflessione, per guardare meglio il paesaggio che mi si apriva davanti.
Un paesaggio (anche questo sia reale che metaforico) nel quale Saffo coinvolge ed è coinvolta; un paesaggio di luoghi concreti che si distendono nel tempo, per esempio fino al giorno di San Valentino del 1900, nell’istituto per fanciulle di Appleyard, in Australia, per un picnic a Hanging Rock; un insieme di figure che appaiono, raccontano e scompaiono nel profondo del loro mito o della loro storia personale. Un paesaggio che mi piace chiamare ‘diaculturale’ (spiegherò più avanti). Venivo da una lettura altrettanto appassionante, il volume di Simone Beta, La donna che sconfigge la guerra. Lisistrata racconta la sua storia (Carocci, Roma 2022) in cui Lisistrata racconta in prima persona secoli di vita, di teatro, di sua presenza nella cultura occidentale e non solo. “L’osservatore esterno e quasi sempre silenzioso nell’epica omerica”, l’osservatore della natura popolata anche dagli uomini in guerra di cui parla Silvia Romani (p. 61) ha già fatto il suo tempo per Saffo, che vive e riscrive nel suo cuore anche la natura. Ne sono tracce i titoli dei singoli capitoli che Saffo avrà sicuramente suggerito a Silvia Romani: il mito, all’orizzonte; barca, mare e vento; della rugiada leggera; avevamo gli occhi troppo belli; oltre il firmamento.
E questo modo di vivere e cercare di dialogare con protagoniste del passato, con Saffo, con Lisistrata, con personaggi reali o concretamente inventati sulla scena non ha nulla di classicismo, di culto per un passato idealizzato, traboccante sentimenti e perfezione.
Ha, invece, la ricchezza della diacultura. Ecco, ora spiego perché da un po’ di tempo (dai miei tentativi narrativi con Il segreto del Tuffatore. Vita e morte nell’antica Paestum, Liguori, Napoli 2020 e L’isola degli dèi. Procida capitale della diacultura, Liguori, Napoli 2021), chiamo così un modo di studiare e raccontare l’antico che ho trovato perfettamente praticato nei libri di Simone Beta e Silvia Romani, un modo che, certo, accanto ad altri, ritengo una delle soluzioni preferibili alla esigenza di novità di tali studi.
La diacultura è, in qualche modo, il pegno di gratitudine che dobbiamo agli autori che in molti e molte abbiamo studiato sin dalla scuola e abbiamo poi insegnato; un modo per restituire, per così dire, ai personaggi antichi, del mito come della storia, lo sguardo insieme emic ed etic secondo la polarità che indicano gli antropologi. Noi moderni dobbiamo fare uno sforzo per diventare emic, cioè per entrare pienamente nella cultura che studiamo, perché dobbiamo sottrarre, liberarci delle acquisizioni di tanti secoli; per rivivere il contesto, i quadri mentali, come ha insegnato Maurizio Bettini (a me un po’ più tardi; Simone Beta e Silvia Romani hanno avuto la fortuna di averlo come Maestro e amico già da giovani), mentre per loro, per gli antichi, si tratta solo di aggiungere, arricchire la loro cultura con quello che è successo dopo, senza perdere il loro sguardo originario; possono, anzi devono essere anche etic, capaci di non perdere la loro cultura mentre impattano la nostra, ed è questo l’aiuto che possiamo offrire: dare loro la possibilità di parlare anche di noi (non solo a noi, come credono gli antichisti ingenui e un po’ predicanti). La Saffo di Silvia Romani, anche se non racconta in prima persona, è capace di parlare di sé e di chi l’ha riletta, riscritta, raffigurata nei secoli, e ne sa parlare con diacultura raffinatissima, percorrendo a galoppo momenti, luoghi, miti.
Questa Saffo, che rimane la ragazza di Lesbo anche se ormai carica d’anni, non si rifiuta di incrociare il suo mond – per quello che è stato – e sottoporsi, contemporaneamente, alle tante interpretazioni e metamorfosi, forse con la curiosità di una ragazza che deve ancora scoprire come cambierà il mondo e come questo in qualche modo la riguardi, se qualcuno sarà capace di darle di nuovo la parola. Sarà poi lei, la ragazza di Lesbo, a trarne le conclusioni, a noi tocca solo darle questa possibilità.
Qualche tempo fa ero stato coinvolto nella presentazione di un volumetto di Sotera Fornaro, Saffo. Ode all’amata, (Mucchi editore, Modena 2020) dedicato alle varie traduzioni e letture del famoso frammento 31, quello che Catullo tradusse a suo modo (carme 51) e che poi – diciamo qualche secolo dopo – Angelo Branduardi musicò (in Altro e altrove, CD 2003), avvertendo però la necessità di un inciso tradotto in italiano, per poi tornare alle parole latine del poeta. Da un po’ di tempo ho fatto caso alla strana assonanza: Ille mi par esse, Quello mi par essere.
Un frammento che si ricorda davvero da sempre, almeno l’inizio, e poi, magari vagamente, la descrizione dello sconvolgimento del corpo e di tutti i sensi. Un frammento nei cui primi due versi appaiono già delineati i protagonisti : moi kenos toi, io, quello, tu. Un’io lirica, un terzo muto ma attivo, un tu con cui l’io stabilisce il contatto.
Continuo a pensare da allora all’immagine di questo frammento, un’immagine di sublime sinestesia, come la definisce Silvia Romani (p. 52 ss.), consentendo a Saffo di incontrarsi con Shakespeare e Giulietta.
E mi arrovello pensando a quella somiglianza/uguaglianza con gli dei. Perché mi viene in mente, direbbe Altan, un’idea che non condivido, visto che non l’ho mai letta da nessuna parte.
Non so perché, ma l’immagine di un dio – inteso al plurale come varietà di situazioni simili – che fronteggia una ragazza mi ha ricordato subito le scene di seduzione che preludono a un rapimento, in genere con esiti drammatici anche se non sempre (inutile elencare: Zeus-Europa, Ade-Persefone; Apollo-Dafne ecc.). Chi si fosse trovato a guardare – in genere ragazze amiche della ragazza oggetto dell’attenzione del dio – avrebbe visto probabilmente un primo impatto spesso innocuo (ma ingannevole) fra il dio e la ragazza, ma poi tutto sarebbe cambiato. Non voglio assolutamente proporre una nuova interpretazione, solo avanzare un’idea forse più vicina al contesto e al quadro mentale antico (non so se ancora catulliano): la minaccia nascosta dell’uomo di cui una ragazza potrebbe innamorarsi. Solo questo; quindi non la beatitudine del dio, o la felicità dell’immortale di fronte alla bellezza, che mi sembra ancora punto di vista maschile; no, la minaccia, insomma, quasi l’avvertimento alla ragazza che sta per cadere vittima dell’inganno, come insegnano i miti, visti da uno sguardo femminile.
E aggiungo, su questo motivo dell’uguaglianza/somiglianza con gli dei, che il libro di Silvia Romani, con le opportune citazioni dei versi di Saffo, fa incontrare altri due frammenti che richiamano proprio quel motivo. Insomma, il tema del rapporto umano/divino potrebbe essere stato declinato da Saffo con una consapevole differenza fra il pericolo costituito (per le donne) dal dio maschio e il modello forse irraggiungibile offerto dalle dee.
Una suggestione, forse, ma che Silvia Romani, amica fedele della ragazza di Lesbo, saprà sicuramente valutare, magari discutendone, come ha saputo fare con magistrale discrezione, con la protagonista del suo bellissimo libro.