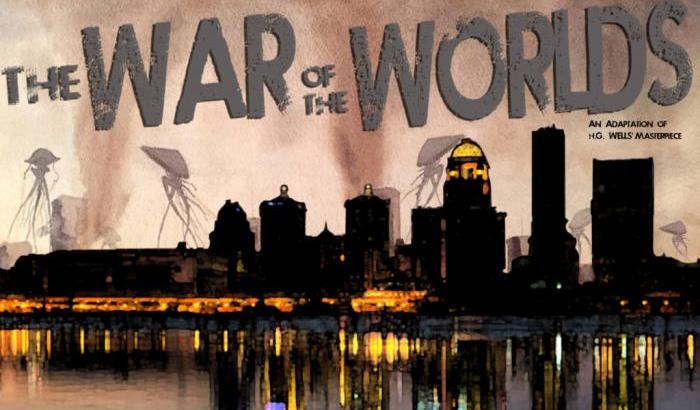Daniele Pugliese
“Ebreo a calci in culo” è il titolo del secondo capitolo di “Questo è un uomo”, la biografia “appassionata” di Primo Levi scritta da Daniele Pugliese e pubblicata da Tessere (www.tessere.org), un libro di 110 pagine (€ 16) – con introduzione di Massimo Giuliani, docente di pensiero ebraico all’Università di Trento ed il ricordo di Andrea Liberatori, il giornalista de “l’Unità” che per ultimo intervistò lo scrittore torinese prima che si togliesse la vita. Anche Pugliese ha lavorato a lungo nel quotidiano fondato da Antonio Gramsci, di cui Tessere ha recentemente pubblicato gli scritti sul giornalismo ed il giornalismo. Pubblichiamo ampi stralci dal secondo capitolo di “Questo è un uomo”, “Ebreo a calci in culo”.
Uno degli ultimi libri che Primo Levi pubblica […] s’intitola La ricerca delle radici. Esce nel 1981 ed è una sorta di antologia personale dei libri che maggiormente lo hanno segnato o verso cui lo scrittore si sentiva in debito.
Che vi compaiano davvero le opere che l’hanno influenzato è, come lui stesso nota nella prefazione, cosa che riguarda i critici […]. Quello che qui c’interessa adesso è la presenza in quel “catalogo” di «una lontana parentela ebraica» affidata a testi di Giobbe, Mann, Babel’ e Shalòm Alechém, alla quale fa da contrappunto «una più vicina parentela in Celan e in Eliot».
E questo per dire che quella che è considerata una delle voci più conosciute e autorevoli dell’ebraismo, «con la sua voce dolce, persuasiva» confessa a un’altra deportata, Edith Bruck: «Mi hanno fatto diventare ebreo».
In quell’intervista e altrove spiega di sentirsi o essersi sentito prevalentemente italiano, ma di non aver rinunciato al peso che gli è stato messo addosso. Certamente decide di essere testimone del destino di coloro che – lo fossero o, come lui, lo fossero diventati – erano stati per questo condannati e, se fosse stato fino in fondo possibile, sarebbero stati completamente annientati. E anche questo, il voler essere testimone, non solo l’esserlo stato, segnerà il suo destino. Ha assistito ai fatti e decide di narrarli. […]
Lui, scrive Stefano Jesurum, «si definisce ebreo al venti, massimo venticinque per cento. Un ebreo anagrafico o, come lui stesso ironizza, di complemento: tuttavia per nessuna ragione al mondo rinuncerebbe ad esserlo».
Trovava giusto che i deportati superstiti considerassero i suoi libri sul Lager «come libri collettivi, come i loro libri» e non dirsi, non essere ebreo gli pareva «un tradimento».
In Vanadio nota che il tedesco ritrovato dopo molti anni non è un tedesco perfetto e si chiede: «ma esistono tedeschi perfetti? O ebrei perfetti? Sono un’astrazione: il passaggio dal generale al particolare riserva sempre delle sorprese stimolanti».
[…] Dice ancora a Edith Bruck: «L’esperienza delle leggi razziali mi ha aiutato a riconoscere, tra molti filoni della tradizione ebraica, alcuni che mi piacevano». Elenca l’indipendenza spirituale con cui i giudei s’erano ribellati ai romani, l’amore per la «discussione appassionata ma precisa» di origine talmudica, l’incontro ad Auschwitz con la civiltà askenazita. Per lui è «una cultura supplementare» e la cultura, dice «non ingombra, non paga dogana, te la porti dietro in qualunque migrazione, da qualunque paese tu sia espulso».
Un programma tutto laico, anzi, di approfondimento della laicità, che caratterizza il suo modo di pensare qualunque sia l’ambito al quale lo si debba applicare, rinunciando al pregiudizio o almeno sapendolo identificare come tale laddove esso è inesorabile, guardando anche ciò che è scomodo, sconveniente e foriero di dolore.
L’esperienza del Lager e del vestito cucito indosso lo spinge comunque non solo a studiare in generale la questione ebraicità – non la questione ebraica che è il modo opposto d’affrontar il tema, eludendo quello dell’identità – o comunque testi che lì affondano, ma anche a pescare nella propria memoria e a raccogliere qualcosa in quella di chi lo aveva preceduto.
Ne viene così fuori quel delizioso affresco dell’universo familiare nel quale Levi è cresciuto o da cui discende che è il racconto Argon, con cui si apre Il sistema periodico.
[…] In questa galleria di personaggi, così come li descrive Levi, spiccano figure come Barbarônín, Barbamiclín o Barbaricô, accomunati dalla radice “barba” con cui in piemontese – e di qui in una sorta di yiddish che potrei chiamare “delle Langhe” a cui lui stesso accenna in un testo del 1982 – si indicano gli zii «in senso assai ampio», così come con “magna” le zie.
Gli avi – o come li chiama altrove i Lari e i Penati – vengono accomunati sotto il nome di argon, il gas nobile o apparentemente inerte che in greco significa “inoperoso”, benché, dice Levi, essi non lo fossero «per guadagnarsi da vivere e per un certa moralità dominante per cui “chi non lavora non mangia”».
La loro inerzia era intima, legata a una tendenza «alla speculazione disinteressata, al discorso arguto, alla discussione elegante», a «un atteggiamento di dignitosa astensione, di volontaria (o accettata) relegazione al margine del gran fiume della vita».
È difficile non vedervi quelle doti di arguzia, curiosità, logica, tentata obiettività, chiarezza, tenacia, riserbo, garbo, understatement di cui Primo sarà campione dentro e fuori i suoi libri. Ed è difficile non vedervi, in queste stesse caratteristiche, un tratto tutto piemontese – o, come lui stesso nota, dei difetti dei piemontesi, «i miei stessi difetti» – al quale, non di meno della propria ebraicità, Levi non vuol rinunciare. […]
Ma per restare all’ebraismo merita segnalare quanto Levi dichiari, in quel testo del 1982 a cui s’è già accennato, di aver recalcitrato ad accettare di definirsi, o esser definito, “ebreo”. Lo fa ammettendo la stessa ostinazione nel rifiutare la patente di “scrittore” e, ancor più di “scrittore ebreo”, anzi, qualunque etichetta.
Ripercorre lì, però, i suoi testi e ovviamente riconosce che Se questo è un uomo e La tregua (il primo è del 1947, ripubblicato nel 1958, il secondo del 1963), trattando dell’internamento e del ritorno a casa dopo il Lager dell’ebreo 174517, sono pertinenti. Così come lo sono vari racconti de Il sistema periodico del 1975: cita Argon, Zinco e Oro e curiosamente non Ferro, Potassio, Nichel, Cerio, parzialmente Argento, e sicuramente Vanadio, denso di interrogativi che riprenderà ne I sommersi e i salvati nel 1986.
In Storie naturali del 1966 e Vizio di forma del 1971 «il tema ebraico vi compare solo saltuariamente» benché alcuni testi «si riconnettono (forse inconsciamente) alla tradizione Midrashica del racconto morale».
I primi 12 dei 36 racconti di Lilìt del 1981 tornano sull’esperienza del Lager, ma anche Disfilassi fa un accenno al tema del razzismo e Decodificazione alle SS.
La chiave a stella «è l’unico fra i miei in cui la tematica ebraica sia assente», tuttavia, aggiunge, «scrivendolo, non mi erano estranei i molti accenni alla nobiltà del lavoro, ed alla sua necessità, che si trovano disseminati nel Talmud».
Poi c’è Se non ora, quando?, appena uscito nel 1982 all’epoca di quello scritto, dove invece il tema è centrale e comporta per Levi lo studio di grammatica e lessico yiddish, di documentazione sulla resistenza ebraica e il ripasso di qualche testo sacro, oltre a qualche debito confessato a Tolstoj e Chagall.
È un romanzo d’invenzione ma documentato. Un «itinerario, plausibile ma immaginario, di una di queste bande», come quella dei giovani sionisti che ne La tregua agganciano il loro vagone a quello dei reduci del Lager o come quella del «gruppo di partigiani ebrei» che Emilio Vita Finzi incontra nel 1945 a Milano e di cui riferisce a Levi nel 1971 o 72. Lui ne prende nota in una paginetta riposta «nel cassetto delle idee giacenti».
Poi la tira fuori ed ecco “il” romanzo di Primo Levi: «“Chiamatelo romanzo”. Credo sia legittimo», dice a Einaudi che ha ricevuto il dattiloscritto non ancora battuto sul Macintosh di cui presto si innamorerà.
[…] Nel 1985, in aprile, accettò di fare un viaggio in America dove il suo romanzo era stato pubblicato da Summit. Il libro, tuttavia, lì ebbe un’accoglienza senza entusiasmi. L’originalità dell’yiddishkeit introdotta in Italia, oltreoceano risultava addirittura artefatta, «imparaticcia», dicono Dini e Jesurum.
E poi, narra la Angier, lì «gli ebrei erano così sicuri, così lontani dal ruolo di minoranza […]. Gli facevano domande solo sull’ebraismo e vedevano in lui solo uno scrittore ebreo. “Mi hanno messo un’etichetta” disse. […] “Non mi piacciono le etichette. Piacciono ai tedeschi”».
«[…] è stato come se mi avessero nuovamente cucito addosso la stella di David» aggiunse in un’intervista nel 1987.
Il fatto è che l’uscita di Se non ora, quando? – che in parte Levi scrive anche per replicare a una polemica scaturita in Israele nel 1979 incentrata sugli interrogativi se, durante il nazismo, gli ebrei si fossero davvero «lasciati condurre al macello senza resistere? Se sì, perché? Se no, quanti, quando, dove, come avevano resistito?» – coincide con l’invasione del Libano meridionale da parte delle forze armate israeliane e, poco dopo, con il massacro di Sabra e Chatila.
Lui, a visitare Israele, c’è stato nel 1968 e non ci tornerà più per il resto della vita, mantenendo però fortissimo il legame con chi ci è andato a vivere: come alla fine di Se non ora, quando? dove una parte della banda prosegue per la terra promessa e una parte si ferma a Milano.
Tornerà invece più di una volta, a partire dal 1965, ad Auschwitz: la targa che ricorda gli italiani, ebrei e non, morti lì, è di suo pugno.