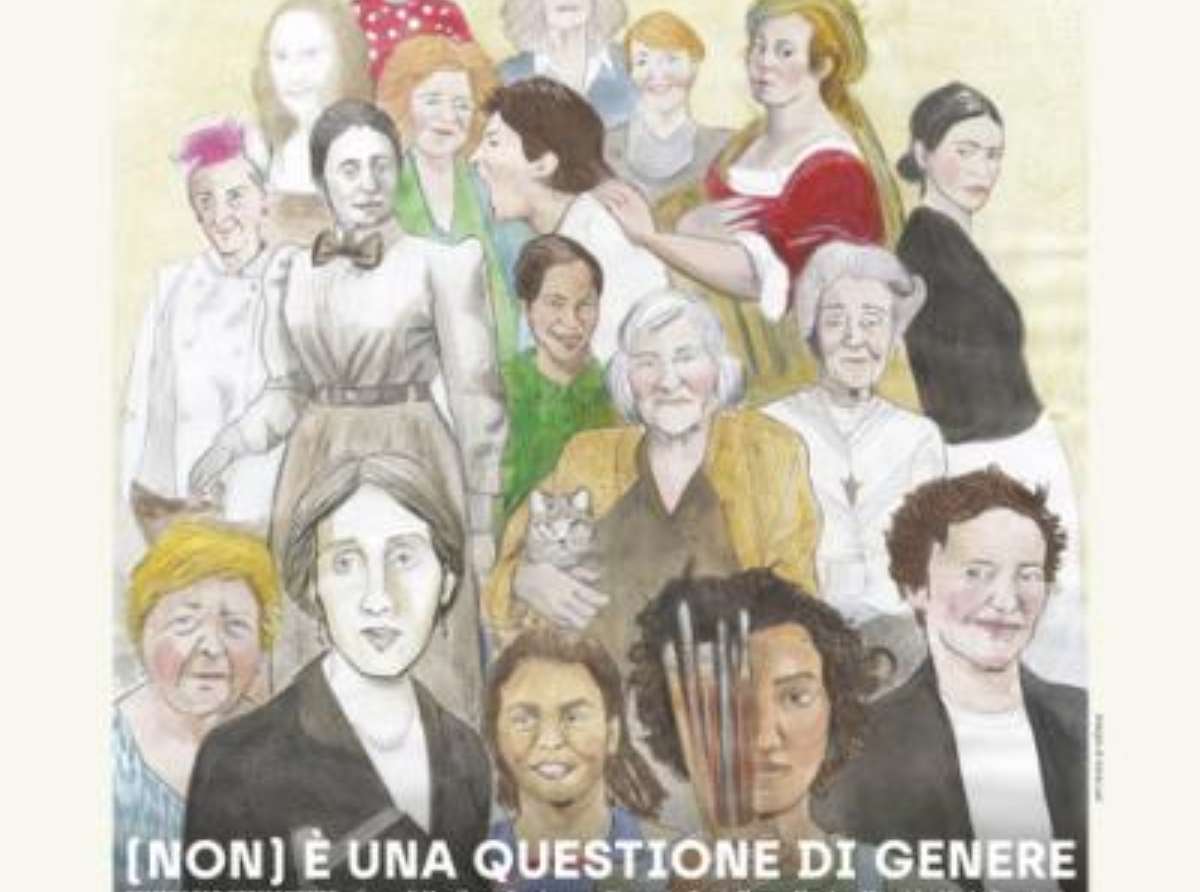di Arianna Scarselli e Giada Zona
E’ iniziata oggi, 11 aprile, la prima giornata dedicata alla Palestina dal titolo “Antropologia e Palestina: come la colonizzazione cambia la produzione dei saperi” presso il complesso San Niccolò (Siena). In una sala affollata gli antropologi Armando Cutolo e Simona Taliani hanno introdotto l’evento. Cutolo ci invita a riflettere sulla violenza in Palestina, dove vengono attuate delle logiche che rischiano di farci perdere la ‘parola’, mentre il nostro desiderio è quella di averla, soprattutto nello spazio universitario, luogo in cui adesso ci troviamo a discutere. Non c’è solamente una resistenza alle armi, ma bisogna resistere anche ad altre logiche, mascherate da chi è complice del silenzio.
In questa prima parte introduttiva interviene anche Taliani, ribadendo i due obiettivi principali di queste due giornate: riposizionare l’antropologia al centro di un dibattito e resistere a un orrore duplice. Gli antropologi devono capire come reagire a un oggetto etnologico che resiste, ma ovviamente si tratta di una questione che coinvolge diversi ambiti disciplinari. Ci troviamo di fronte a un progetto di disumanizzazione e criminalità amministrata, volto a ripulire e svuotare territori. Vi è il collasso di una società, la nostra, e quella palestinese. “Bisogna ritornare a pensare politicamente e collettivamente” conclude il suo intervento l’antropologa dando il via a una sessione di riflessioni da parte di Ruba Salih (Università di Bologna), Rema Hammami (Università Birzeit), Noureddine Amara (Università di Zurigo), Mahmoud Hawari (Università Birzeit) e Izzeddin Araj (Università di Ginevra).
“Non basta condannare le morti e denunciare ciò che sta accadendo ma bisogna approfondire e capire le cause all’origine (della visione distorta di ciò che sta accadendo in Palestina) e il modo in cui si sono evolute nel tempo” queste le parole, tradotte, dell’antropologa dell’Università di Bologna Ruba Salih. Ecco perché -dice- che per parlare di Palestina non possiamo far iniziare tutto dal 7 ottobre ma è doveroso analizzare le violenze e i soprusi subiti in più di settant’anni dai palestinesi.
Salih fa riflettere su alcune contraddizioni profonde nella narrazione israeliana degli eventi succedutisi dopo il 7 ottobre 2023, in primis per ciò che riguarda gli attacchi subiti dalla popolazione, dai giornalisti e dai soccorritori sanitari. E ricorda come lo scorso anno abbiamo assistito a un risveglio collettivo della popolazione studentesca che nel corso dei primi mesi del 2024 ha occupato le università di tutto il mondo con le “acampadas”; anche in quel caso la narrazione è stata fortemente manipolata con l’obiettivo di descrivere questi moti come violenti e pro-Hamas.
Un anno e mezzo, sottolinea la Salih, dove abbiamo assistito al tentativo di giustificare e normalizzare le azioni genocidiarie compiute da Israele in nome dell’autodifesa, cosa del tutto insensata definirla tale quando contiamo migliaia di morti tra donne, bambini e anziani. Ma ciò che sembra è che per la politica il problema non sia il fatto che stanno uccidendo migliaia di persone ma che ne stiamo parlando.
Ha poi preso la parola Rema Hammami dell’Università di Birzeit affermando che nel corso dei decenni la repressione violenta di Israele ha portato a una ‘Resistenza’ sempre più forte. Gli accordi, il 1948, la Nakba, tutto questo è stato subito dai palestinesi ma non in silenzio. Quel silenzio -dice -che è il problema di oggi, con la grande politica che non parla quando sul tavolo ci sono le vite dei palestinesi e con anche la giustizia e la giurisprudenza che sono asservite ad esso favorendo la cancellazione del popolo palestinese. Una cancellazione tanto fisica quanto politica e storica. Ad oggi tutte le generazioni del popolo palestinese hanno vissuto la guerra, anche più di una volta ma la violenza attuale non ha precedenti. “Quale antropologia vogliamo perseguire?” Hammami è certa che l’antropologia deve essere vista come una via per portare una nuova narrazione che tenga conto della realtà palestinese attuale e di quella storica.
Successivamente il ricercatore Noureddine Amara ha raccontato la sua storia. Dopo il dottorato di storia decoloniale, presso l’Università di Zurigo, condivide con l’università di Siena e con la rete “Antropologə per la Palestina” lo stesso obiettivo, ovvero discutere della questione palestinese. Ma non è stato così semplice raggiungere questo traguardo, poiché nonostante abbia proposto all’università svizzera numerose proposte di incontri sul tema della Palestina, le sue idee non sono state mai accettate. Eppure la richiesta di Amara era solo dare spazio alle ricercatrici e ai ricercatori palestinesi.
Dopo aver trascorso un periodo di silenzio, il ricercatore ha recentemente provato ad organizzare un seminario invitando altri studiosi che avrebbero discusso della questione coloniale. Ma ancora una volta è arrivato un altro “no” da parte del suo ateneo che lo sta sottoponendo a un procedimento di valutazione disciplinare. Noureddine Amara ci sollecita ad identificare gli alleati, visto che sappiamo chi sono i nemici e, sostiene, che ci troviamo in una trappola coloniale che ci fa ripetere, in modo circolare, le questioni relative alla violenza. Non dobbiamo più giustificare questi attacchi, ricordandoci che il crimine coloniale si può commettere con e attraverso il linguaggio.
Per distruggere un popolo bisogna cancellarne l’identità storica, culturale e tradizionale; ne ha parlato l’archeologo dell’università di Birzeit Mahmoud Hawari nel suo intervento su colonialismo, archeologia e appropriazione del patrimonio culturale. Spiega che l’idea che il popolo colonizzatore sia portatore di cultura e sapere in terre dove non esiste nulla è l’idea che l’Occidente suprematista ha portato avanti per secoli. Illustra come il colonialismo in Palestina ha origini antiche legate al bisogno europeo di aprire nuove vie commerciali con l’Asia e alle colonie evangeliche e protestanti del 1800 e al successivo piano israeliano. Nel corso del diciannovesimo secolo si è sviluppata anche “l’archeologia biblica”: pseudo-scienza che ha cercato di adattare, forzandola, la realtà ai testi biblici. Per giungere poi alla vera e propria manipolazione delle scoperte o la costruzione di reperti.
Hawari, con l’aiuto di immagini, ci mostra infine come edifici storici dall’enorme valore culturale sono stati trasformati in sedi militari, come siti archeologici sono divenuti nuclei di colonie e come le moschee sono state trasformate in sinagoghe. Nemmeno siti Unesco sono stati risparmiati e adesso sono solo macerie, laddove secoli e secoli fa culti e popoli diversi convivevano pacificamente, oggi resta una scia di morte, dolore e distruzione.
Il convegno si è concluso con l’intervento di Izzeddin Araj provieniente dall’Università di Ginevra che ci ha parlato delle sue ricerche concentrate sulla politica di riproduzione nel contesto del colonialismo israeliano.
Domani sabato, il convegno, continuerà nella vicina Corte dei Miracoli
Argomenti: Palestina